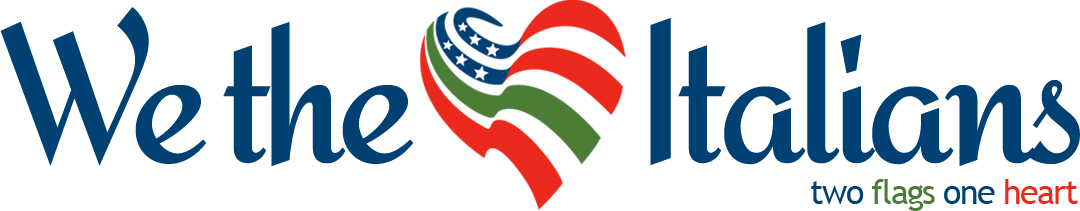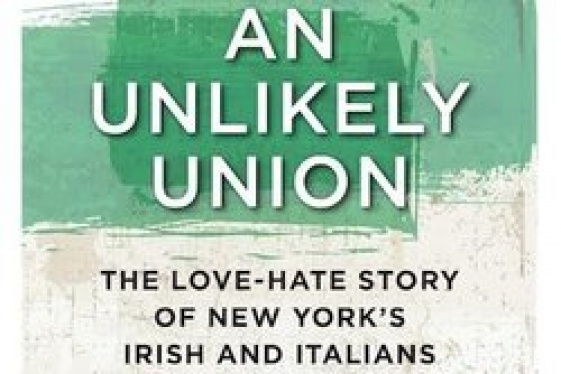Essere o non essere Italoamericani? Un’introduzione. [da "Essere o non essere Italoamericani", Nuova Prosa n.50, 2009]

di Emanuele Pettener
Sono un Italoamericano. Anche se appartengo a quella generazione, sbarcata in America all'alba del 2000, che non lo ammetterà mai. Siamo emigranti (siamo venuti a studiare e lavorare negli Stati Uniti perché in Italia non c'erano possibilità, non c'era lavoro) abbiamo un senso della patria molto flebile (suvvia, non siamo nemmeno Francesi) giuriamo che in Italia non ci torneremmo mai ("a fare cosa?") siamo critici nei confronti del modus vivendi americano benché l'America ci abbia davvero dato opportunità nemmeno immaginabili in Italia (è innegabile) ci lusinghiamo tra noi a parlar male dell'Italia come se l'avessimo scampata bella (forse è vero) ma, consapevoli di come l'Italia sia di moda negli Stati Uniti, ci identifichiamo orgogliosamente come "Italiani". "Italiani all'estero". "Italiani in America".
Mai – mai – Italoamericani.
Eppure dieci anni fa siamo arrivati qui, sulla soglia dei trent'anni, senza valigie di cartone ma sotto sotto con la stessa speranza dei nostri compatrioti di cent'anni fa: che le strade fossero lastricate d'oro. Eppure l'America la sognavamo da piccini, grazie a Topolino e Paperino, a Hollywood, alla tivù, a "Dallas" ed "Happy days," ai romanzi di Mark Twain prima e Scott Fitzgerald poi - il nostro immaginario pregno dei cieli sconfinati in Technicolor, di spazi illimitati ricolmi di sole, di rosse pompe di benzina, vecchi motel e bottiglie di latte sulla soglia di casette stile Paperopoli, e naturalmente i grattacieli di New York, le sue strade luccicanti di pioggia con la voce di Frank Sinatra in sottofondo, i teatri di Broadway (il sapore intenso, magico, che sprigionavano – proustianamente - i nomi di luoghi americani, Grand Canyon, Far West, California...)
Eravamo Italoamericani ancora prima d'arrivarci, in America.
Non ci diciamo mai Italoamericani, eppure la nostra lingua comincia pericolosamente a corrompersi, la struttura inglese si sovvrappone e si confonde a quella italiana, alcuni di noi si lamentano di non riuscire più a scrivere in Italiano, cominciamo a pronunciare frasi quali "Ho avuto un buon tempo" (I had a good time) o "Sono aspettato di fare questo" (I'm expected to do this) se non addirittura "sono supposta" (I'm supposed). Spesso la parola inglese arriva prima di quella italiana oppure formuliamo, più o meno coscientemente, orrendi neologismi: in ambiente accademico, scriviamo un paper (un saggio) o droppiamo un corso (to drop, ritirarsi). E non solo questo: non è più scandalosa l'idea di far colazione con uova e salsicce, viviamo in case più grandi di quello che ci servono, facciamo debiti, celebriamo Thanksgiving, beviamo caffé lunghissimo davanti a una partita di football, alcuni di noi – quelli ormai senza speranza – mangiano maccheroni&cheese.
Ma non ci diciamo Italoamericani.
Forse perché la parola ha in sé una sfumatura grottesca – Italiano è stato mozzato e Americano si affardella sulle spalle Italo, come un peccato originale da cui è impossibile liberarsi. C'è un che di macchiettistico, di ridicolo, di oltraggioso, di miserabile che risuona in Italoamericano – provate a chiedere a un Italiano le prime cose che gli vengono in mente a pronunciare Italoamericano, vi dirà spaghetti, mandolino, o sole mio (gli Italoamericani hanno ereditato l'immagine stereotipica che per decenni è gravata sugli Italiani) . Chiedetelo a un Americano, vi dirà: mafia.
Gli Italoamericani, si badi, hanno le loro colpe – si veda il saggio di Anthony Tamburri – a cominciare dal fatto che difficilmente si identificano come tali, nemmeno i più anziani: si dicono Italiani ma l'Italia non l'hanno mai vista o non la vedono da anni (però se la sono inventata, come noi più giovani, prima d'arrivare, ci siamo inventati l'America: questa Italia immaginaria, nutrita da vecchi racconti, dalla nostalgia, dagli inganni della memoria – ecco di nuovo Proust - occupa nella loro vita uno spazio maggiore di quello che occupa nella vita di chi l'Italia la vive quotidianamente). Inoltre non parlano una parola d'Italiano (anche se molti sono convinti di sì) e nei loro ristoranti italiani offrono specialità italiane mai sentite nominare in Italia.
Ma per tutte queste ragioni siamo gente affascinante, noi Italoamericani, difficili da definire: si pensi che io, Italoamericano del 2000 che non s'è mai definito tale fino a questo momento, insegno Italiano a giovani studenti che sono nipoti o bisnipoti di emigranti. Questi studenti – orgogliosamente – si dicono Italiani. Si badi, Italiani. Non Italoamericani (ci risiamo). Perché l'Italia è diventata, nell'immaginario americano, soprattutto quello dei giovani studenti, catalizzatrice di tutto ciò che non è Americano, è il Paese dove corre la vita vera – tanto per usare una frase che usava Pavese per definire la bramata America settant'anni fa – perché gli Italiani sanno vivere. Chi ha messo in giro questa bufala, non so. Ma la cosa interessante è che questi studenti dicono che vogliono imparare l'Italiano per poter parlare con i nonni italiani. Non con i genitori, che non sanno spiccicare una parola d'Italiano e questi sì, si definiscono Americani, in quanto i loro genitori – i nonni dei miei studenti – han fatto di tutto per americanizzarli, per fare in modo che non apparissero italiani, che non soffrissero gli stessi pregiudizi sofferti sulla loro pelle. Qualcosa è cambiato.
Si può capire come un' identità così ricca di impulsi da diverse direzioni, così (ecco, mi viene l'aggettivo inglese invece di quello italiano) fluida e in perpetuo smottamento (ma come tutte le identità, probabilmente) sia divenuta origine di meditazioni, scritture, studi intensi, appassionati, vitali – spesso sottovalutati, sia in Italia che in America in quanto italoamericani ma anche perché, mi sembra, diversi scrittori e intellettuali che s'identificano come italoamericani stanno chiusi nel guscio, rischiando di autoghettizzarsi e di raccontarsela fra loro.
L'importanza di questo volume sta proprio in questo: proporre – anzi, raccontare - al pubblico italiano (non al pubblico italoamericano) una realtà di storie, riflessioni, produzioni intellettuali ed artistiche ancora sconosciute. Sbarazzandosi degli stereotipi sulla scrittura italoamericana, cresciuti all'interno e all'esterno della comunità italoamericana. È un mondo vivo, palpitante, non è solo nostalgia e lamenti e cibo – anche se è pure questo, certo – e forse vale la pena conoscerlo.
Spero, quindi, che il volume offra uno spettro più ampio possibile di temi e di scritture – si va da quella più scanzonata e briosa a quella più analitica, dal racconto più divertito a quello più sofferto, dall'autobiografia alla storia, dalla critica letteraria alla fiction. Il volume si divide idealmente in tre parti. Nella prima gli autori raccontano e invitano il lettore a condividere nodi, sfaccettature e passioni dell'identità italoamericana. Tanto che lo scritto autobiografico di Louise DeSalvo, che apre il volume, s'intitola: Diventare italoamericana (dal Meridione). A seguire, L'anno di Cristoforo Colombo, dove Alessandro Carrera ci racconta le tragicomiche vicende di un Italiano alle prese con le celebrazioni di Colombo, figura sacra per gli Italoamericani. Sacra è anche la figura dell'Italoamericano padre di famiglia, cattolico e virile: ma Ilaria Serra, in La letteratura gay italoamericana: le streghe son tornate smonta un altro stereotipo legato all'italoamericanità, quella del machismo, ed illustra l'intrecciarsi di identità italoamericana ed identità omosessuale. Dopo il già menzionato saggio di Anthony Tamburri Uno stato d'animo italiano/americano, che critica dal di dentro certi aspetti della cultura italoamericana, chiude la prima sezione il saggio di Peter Carravetta, Migrazione, storia, esistenza che fissa un punto di partenza per qualsiasi indagine su cosa siano gli Italoamericani oggi, risalendo la corrente e andando all'origine per interrogarsi sulla storia e sulla natura del migrare.
Come naturale sviluppo della prima parte, dedicata agli aspetti dell'identità italoamericana, e introduzione all'ultima parte, dedicata alle short-stories di gusto italoamericano, ecco tre saggi specificatamente d'analisi letteraria: ma anche qui, tre momenti assolutamente diversi, tre autori lontanissimi fra loro. Martino Marazzi, in Lacrime e libertà. Profilo di Ludovico Michele Caminita c'introduce all'opera di uno scrittore italoamericano insolito, capace di adoperare ironicamente uno dei brani più celebri di Manzoni per farne spunto di denuncia sociale. Nel Diritto all'etnicità:
Italoamericanità nei legal thriller di Lisa Scottoline Chiara Mazzucchelli, demolendo un altro tabù, si occupa di un'autrice, Lisa Scottoline, che pur definendosi italoamericana, pur essendo i suoi personaggi italoamericani con tutto quel che ne consegue, pur trattando, come si legge nel saggio della studiosa, temi cari alla cultura italoamericana – viene considerata, in quanto autrice popolare, indegna d'entrare nei santuari dell'accademia. Infine, Robert Viscusi, in Spaghetti Western ci parla di sogno americano, tratto essenziale per gli Italoamericani, che nella vicenda di The Fortunate Pilgrim di Mario Puzo si mescola continuamente all'immaginario prodotto dall'epopea Western.
A concludere il volume, la fiction. Il luogo comune (il che non vuol dire che sia del tutto falso) sulla fiction italoamericana è che si parli sempre di cannoli, nonne, e rosari. Rita Ciresi invece, vincitrice del prestigioso Flannery O'Connor Award, autrice che si identifica assolutamente come Italoamericana e non solo per il cognome, si presenta per la prima volta al pubblico italiano con un racconto che non ha nulla di specificatamente italoamericano, e la donna di cui narra potrebbe essere qualsiasi donna di qualsiasi etnia: gli scrittori italoamericani non scrivono solo per gli italoamericani.
Con Terremoto napoletano, John Domini ci propone il primo capitolo del suo nuovo romanzo, nato originariamente come short-story e qui presente in quanto tale, laddove una famiglia di Americani si trova d'improvviso catapultata a Napoli.
Mi benedica Padre, di Fred Gardaphe, narra invece di un giovinetto italoamericano che deve sbrigarsela fra un'esuberante e gioiosa sessualità adolescenziale e i precetti cattolici della mamma e di padre Frank.
A chiudere il volume, Vito di Salvatore Mammano, un gioiellino che ha una vicenda romantica alle spalle: un giorno del 2007 il figlio Nick, professore di chimica in pensione, ha scovato dei fogli sparsi, fittamente scritti a mano, tra le pagine di vecchi libri di scuola e quelle di un suo vecchio e consunto quaderno d'appunti, oltre a una ricevuta per la riparazione di un televisore datata 1948: erano l'autobiografia del padre, morto nel '64. Ha consegnato i fogli ad Ilaria Serra, sempre in cerca di autobiografie d'emigranti, che m'ha segnalato in particolare l'episodio di Vito, che ho trovato straordinario sia per la scrittura sia per la sua modernità - in quest'epoca di religiosità ostentata e strumentalizzata. A mia richiesta, Nick Mammano ha accettato di limarlo per eliminare i rari refusi, qualche ripetizione ed altro, ma lasciandolo intatto nella forma e nella sostanza. Io l'ho tradotto fedelmente e qui è presentato come short-story proprio per il suo squisito andamento di racconto, perché l'autore evidentemente non si limita ad informare ma reinventa il ricordo, perché sembra scritto per un pubblico e mi sembra suggellare la varietà di questo volume, dimostrando peraltro come lo storytelling, talento attribuito più spesso ad altre etnie, possa appartenere anche un uomo nato a Brooklyn all'inizio del secolo, figlio di Siciliani - un Italoamericano.
You may be interested
-
'Phantom Limb': A Conversation With Dennis...
Dennis Palumbo is a thriller writer and psychotherapist in private practice. He's the auth...
-
“The Hill” St. Louis’ Little Italy
When the fire hydrants begin to look like Italian flags with green, red and white stripes,...
-
An Unlikely Union: The love-hate story of Ne...
Award-winning author and Brooklynite Paul Moses is back with a historic yet dazzling sto...
-
Former Montclair resident turns recipes into...
Former Montclair resident Linda Carman watched her father's dream roll off the presses thi...
-
Polisena delivers address as state lawmakers...
"Italian-Americans came to our country, and state, poor and proud," Johnston Mayor Joseph...
-
The “Little Italies” of Michigan
In doing reseach for this post, I was sure that Italian immigrants found their way to Detr...
-
Ybor City – Florida’s Little Italy
"The people who had lived for centuries in Sicilian villages perched on hilltops for prote...
-
''La Gente di Mulberry Street'' presentato a...
Valsinni- Italia, terra di emigranti. Presentato a Valsinni il nuovo saggio storico di Raf...